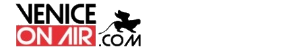Sul festival shakespeare al teatro romano di Verona, Martino Periti ha scritto un testo-recensione su Bo Live, il giornale web dell’ateneo di Padova. Uno dei rischi maggiori, nell’affrontare una messinscena di Misura per misura, è indulgere al piacere delle tinte forti sconfinando nel kitsch. Inducono in tentazione la cupezza dell’argomento, la morbosità dei temi, la lusinga dell’eterna catena potere – abuso – violenza – sesso. La regia di Paolo Valerio, nella produzione Stabile di Verona – Teatro della Toscana che ha debuttato al Teatro Romano durante la settantesima stagione del festival shakespeariano, sembra andare nella direzione opposta, e sceglie la sobrietà come criterio guida dell’intera rappresentazione, connotata soprattutto dalla fuga da eccessi interpretativi a sfondo sadico o postribolare, visti fin troppo, in passato. Il Duca di Vienna, stanco delle sregolatezze dei sudditi, annuncia di allontanarsi dalla città, e incarica il severissimo vicario, Angelo, di sostituirlo. In realtà il Duca vigila, travestito da frate. Una volta al potere, Angelo punisce la lussuria dei cittadini, ma non esita a ricattare una novizia, Isabella, proponendole di concedersi a lui in cambio della vita del fratello Claudio, colpevole di fornicazione. Toccherà al Duca, constatate ipocrisie e virtù, salvare Claudio, colpire gli iniqui, riscattare gli umiliati. E fare di Isabella la propria sposa. Masolino D’Amico, che ha curato la traduzione per l’allestimento veronese, sottolinea come nel testo shakespeariano i protagonisti “non recitano, bensì vivono”: le contraddizioni che costellano la nostra esistenza si ritrovano in questa costante ambivalenza dei personaggi e delle loro intenzioni, e il “lieto fine” che ci consegna quattro matrimoni non è il trionfo della giustizia, ma dell’arbitrio del Duca. Proprio per la perfetta modernità che ogni opera shakespeariana cela tra le sue pieghe, anche questa lettura di Misura per misura sembra credere all’autosufficienza del testo, ed evita qualunque egocentrismo reggendosi su un unico artificio, l’immaginare il Duca come regista televisivo di un reality. In effetti, il protagonista Massimo Venturiello passa di continuo dalla scena alla platea, dotato com’è di una postazione davanti al palco che simula, per l’appunto, una regia televisiva, con monitor e apparecchiature. La suggestione, ha aggiunto Martino Pariti nelle sue valutazioni, nel suo è rafforzata dalla scenografia, coerentemente semplice, di Antonio Panzuto: un insieme di fondali di tessuto scorrevoli che, pur funzionali all’azione e ai movimenti dei personaggi, fungono soprattutto da teloni. Sui quali vengono proiettate ora fantasie decorative ora le stesse immagini in diretta degli attori, e in particolare del Duca che, dallo scranno fuori scena, osserva e manipola i personaggi come un conduttore del “Grande Fratello”. Ma al di là dell’idea portante, che una volta svelata non propone, nel corso dello spettacolo, particolari sorprese o variazioni che ne giustifichino l’utilizzo, la regia sembra voler costantemente cedere il passo alla forza dell’intreccio e del testo, relegando se stessa a una presenza fin troppo discreta, limitata a riferimenti come il cerchio fluorescente che racchiude i dialoghi tra Angelo e Isabella, un confine vizio-virtù troppo facile da attraversare, in entrambi i sensi. In questa generale discrezione spiccano le musiche di Antonio Di Pofi. Qui la misura coincide con la precisione e la ricercatezza: gli interventi sono concisi ma perfettamente integrati. Sonorità classiche, a volte sacrali, a formare, con un assolo di violoncello, un canto a cappella, una melodia bachiana, magnifici contrappunti all’azione, o pause ispirate. Più appariscenti, invece, i costumi di Luigi Perego, in cui su tagli anni Venti si innestano motivi espressionisti e decori tribali: un’alchimia in sé riuscita, ma che appare slegata da un allestimento che, per la sua essenzialità, contrasta con qualunque elemento altisonante. Quanto agli attori, anche la recitazione sembra adeguarsi a un generale indirizzo di tenuità. Massimo Venturiello è in genere un interprete di grandissima sensibilità, ma stavolta dipinge il suo Duca di Vienna con colori troppo sfumati. Si avverte, soprattutto nella prima parte, l’assenza di pause e silenzi, non solo da parte sua ma nell’impostazione generale: quasi la preoccupazione primaria fosse di non eccedere nella durata, e non, invece, di lasciare allo spettatore istanti decisivi per decantare emozioni e assimilare passaggi cruciali. Simone Toni è, al contrario, un Angelo muscolare, più atletico che riflessivo, più rapido che malizioso; e il Lucio di Alessandro Baldinotti è troppo lezioso e petulante. Il cast si regge, quindi, su Camilla Diana, che offre a Isabella una gamma espressiva completa, spaziando dal vigore della rivendicata purezza alla fragilità dell’impatto con il mondo. Tra gli altri, molto bravo Marco Morellini, un Bargello che meriterebbe più spazio. Pubblico caloroso, ma non foltissimo.