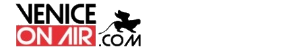A Palazzo Bo s’insedia nel 1539 l’università di Padova (fondata nel 1222) e nel tempo è divenuto uno degli atenei europei più illustri e quello in Italia più frequentato da studenti stranieri. Prima di allora l’Hospitium Bovis (l’antica locanda del bove) era noto soprattutto come uno degli alberghi più grandi e lussuosi della città. Il nome pare derivare da uno dei primi possessori, un macellaio di nome Marcolino Bonzanini, che nel 1405 lo avrebbe ricevuto dal signore della Città Francesco Da Carrara; altri invece ritengono che l’appellativo Bo venga dalla vicina via dei macellai o delle Beccarie (l’attuale via Cesare Battisti). L’attuale edificio, risultato dall’accorpamento di diverse costruzioni di epoche diverse, sorge in una zona abitata fin dall’epoca romana, all’incrocio tra il cardo minor cittadino e il fiume Medoacus, il moderno Bacchiglione. Qui un tempo sorgevano il porto fluviale un antico ponte romano, ancora parzialmente visibile da un attiguo sottopassaggio. Daniele Mont D’Arpizio per Bo Live, il giornale web dell’ateneo, propone in un suo testo i luoghi nascosti di Padova e tratta, in questo caso, la storia e le potenzialità scientifiche ed accademiche del palazzo Bo, da quasi 5 secoli sede dell’università e punto di riferimento dell’accademia italiana. Dietro la facciata austera e un po’ grigia si apre il chiostro, che ancora oggi continua a sorprendere il visitatore per il contrasto tra la sobria bellezza del doppio loggiato, progettato da Andrea Moroni, e il caos organizzato degli stemmi araldici, che a centinaia coprono i muri e le volte (ph Massimo Pistore). Memorie, in pietra o dipinte, lasciate nel corso dei secoli da generazioni di rettori, studenti e professori. Quando si pensa a Palazzo Bo vengono in mente principalmente la storia e la bellezza di cui è pieno: eppure si tratta anche e soprattutto di un luogo di scienza. Qui, hanno studiato figure come Copernico e Andrea Vesalio; qui – tra il 1592 e il 1610 – ha insegnato Galileo Galilei: il geniale osservatore del cielo e inventore del cannocchiale, l’immaginifico scopritore delle leggi che regolano la gravità e l’inerzia. Sulle tracce del grande pisano si sale lungo uno dei due scaloni che portano al loggiato superiore: magari quello di destra, tanto per dare un veloce saluto a Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, confinata quasi in disparte su un pianerottolo. Chi direbbe che da questo luogo quasi tre secoli e mezzo fa, il 25 giugno 1678, uscì la prima donna laureata al mondo? Perché Padova e la sua università sono un po’ così: amano sorprendere più che ammaliare, le loro cose non te le spiattellano in faccia. Se ti interessano te le devi guadagnare. Nella Sala dei Quaranta, nell’angolo a nord-ovest del loggiato superiore, ancora oggi è conservata la cattedra di Galileo. I Quaranta sono una selezione di studenti stranieri illustri, fissata nel 1942 dai ritratti a tempera di Giacomo Dal Forno. Tra loro uomini di stato e letterati, ma anche diversi scienziati: come William Harvey, che proprio a Padova fece la scoperta a cui deve la sua fama, quella della circolazione sanguigna. La cattedra, a prima vista è una sorta di palco fatto di assi di legno assemblate alla buona. Fino al 1856 sorgeva nell’attigua Aula Magna, in origine la Scuola grande dei legisti: qui a Galileo fu eccezionalmente permesso di tenere le sue lezioni, causa il grande afflusso di uditori. Durante le dimostrazioni, molto amate dagli studenti perché sapeva illustrare con chiarezza anche i temi più difficili, il grande scienziato introduceva il pubblico ai concetti base della meccanica: spiegava ad esempio il movimento di un proiettile come la composizione di due moti dovuti a due forze diverse, la gravità e l’inerzia. Per poi aggiungere che, se si fosse riusciti a imprimere la forza sufficiente, il proiettile sarebbe riuscito a fare il giro completo della Terra: lo stesso principio sfruttato oggi dai satelliti. Di fronte alla cattedra, sempre in sala dei Quaranta, un’iscrizione posta su un cippo nero ci avverte che qui in origine era custodita anche un’altra reliquia galileiana, stavolta nel senso più pieno (e macabro) della parola: addirittura un pezzo del suo corpo. Per capire come sia arrivata fin qui occorre però fare un passo indietro nel tempo: quando il 12 marzo 1737 nella Basilica di S. Croce a Firenze si procede all’apertura della tomba di Galileo, in vista della definitiva collocazione dei resti in un più prestigioso monumento all’interno della stessa chiesa, all’esumazione sono tra gli altri presenti Giovanni Vincenzo Capponi, rettore dello studio fiorentino, Anton Francesco Gori, professore di storia antica, e Antonio Cocchi, professore di anatomia e di filosofia naturale. Ognuno di loro tornerà a casa con un ‘ricordo’: il Capponi asporta dalla salma due dita, mentre un altro dito va al Gori e al Cocchi tocca la quinta vertebra lombare. I tre reperti seguiranno poi strade diverse: il “dito medio” raccolto da Gori “onde – scrive Giovanni Battista Clemente Nelli – la mano illustre / Del Ciel scorse segnando i spazi immensi / E nuovi Astri additò”, dal 1927 è al Museo di storia della scienza di Firenze (oggi Museo Galileo), e il rapper Caparezza gli ha persino dedicato una canzone. La vertebra passerà invece per varie mani, prima di essere acquistata dal medico vicentino Domenico Thiene e infine donata nel 1823 all’università di Padova: oggi è conservata al sicuro in un altro recesso di Palazzo Bo, mentre al suo posto è esposto un simulacro. Per quanto infine riguarda le due dita prelevate dal Capponi, un pollice e un medio destri, furono considerate disperse per decenni, prima di essere fortunosamente ritrovate, Ma il Bo non è soltanto collegato a Galileo. Intorno al loggiato superiore del cortile antico si aprono le aule un tempo riservate alle facoltà, dove ancora oggi vengono discusse le tesi e si celebrano le lauree. Come la sala della facoltà di scienze, dove nel 1734 furono sistemate le collezioni naturalistiche di Antonio Vallisneri, che qui rimasero fino al 1854 costituendo il primo vero e proprio museo di scienze naturali dell’università. O come la medievale sala della facoltà di medicina, dove in una teca sono conservati otto teschi umani. Un altro funereo cimelio che la tradizione attribuiva ad alcuni illustri professori che avrebbero donato il loro corpo alla scienza. Recenti indagini raccontano però un’altra storia: fu probabilmente Francesco Cortese, professore di anatomia e ultimo docente ad utilizzare il teatro anatomico per le sue dissezioni, tra il 1838 e il 1848, a iniziare a collezionare i crani di alcuni maestri e colleghi. Forse per i suoi studi di frenologia, una pseudoscienza allora molto in voga che attribuiva proprietà particolari alla forma del cranio. Probabilmente Pietro d’Abano (1257-1315), celebre medico e astrologo accusato anche di stregoneria e negromanzia, non poté mai visitare questo luogo, ma il suo ritratto in pietra sembra incombere nell’oscurità della sala.
agricoltura
ambiente
architettura
arte
astronomia
Comuni
comunicazione
Cultura
Economia
EUROPA
filosofia
Innovazione
letteratura
libri
medicina
Paesi Mediterraneo
ricerca
sanità
scienza
Telecomunicazioni
territorio
tradizioni
trasporti
Turismo
università
PALAZZO BO PADOVA: UNO DEGLI ATENEI EUROPEI PIU’ ILLUSTRI