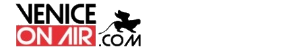Il made in Italy è da sempre riconosciuto come un’eccellenza e in questo mondo variegato, che sa unire tradizione e innovazione, la Olivetti di Ivrea può essere senza dubbio considerata una punta di diamante. La sua storia e i risultati ottenuti hanno portato Ivrea all’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco come 54/mo sito italiano (“bruciando” le colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, che ci riproveranno l’anno prossimo). Sul Bo Live, il gionale web dell’ università di Padova, ha scritto un testo Anna Cortellazzo (foto di UniPd). Quello della Olivetti, però, non è un semplice successo industriale: il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Alberto Bonisoli ha rilevato che questo è “un riconoscimento che va a una concezione umanistica del lavoro propria di Adriano Olivetti, nata e sviluppata dal Movimento comunità e qui pienamente portata compimento, in cui il benessere economico, sociale e culturale dei collaboratori è considerato parte integrante del processo produttivo”. Adriano Olivetti è stato uno dei pochi imprenditori italiani ad essersi reso conto che il successo di un’azienda non può prescindere dal benessere dei suoi dipendenti. Il padre Camillo, che fondò l’Olivetti 110 anni fa, per prima cosa mise il figlio a lavorare come operaio alla catena di montaggio. Non ci è dato sapere se è stato questo esordio a far maturare in lui quella concezione illuminata che è rimasta costante per tutto il periodo della sua dirigenza, ma quello che è certo è che dagli anni Trenta agli anni Sessanta la Olivetti ha vissuto il suo periodo d’oro anche grazie alla lealtà dei suoi dipendenti (in un decennio il fatturato aumentò del 500%). Dopo tanti anni rimangono solo le ceneri di un sogno, che però rimane ancora vivo nei ricordi. Quello di Adriano Olivetti era sicuramente un progetto che mirava al successo e quindi al guadagno, ma era sua convinzione che questo guadagno dovesse essere reinvestito anche a beneficio della società in cui l’azienda operava: Adriano sentiva di avere, come imprenditore, una responsabilità sociale, che lo rese portavoce di una sorta di umanesimo laico che spingeva gli operai di ogni livello a comprendere che non erano solo vani ingranaggi di un processo produttivo, ma persone che davano un reale contributo al progresso. I loro pensieri, i loro sentimenti, erano importanti: dovevano avere la possibilità di guardare più lontano, di sentirsi parte di qualcosa di più grande di un ripetitivo tran tran. “La fabbrica non può guardare solo all’indice dei profitti. Deve distribuire ricchezza, cultura, servizi, democrazia”, ha sostenuto Adriano Olivetti. E così l’industria di Ivrea si consolidava sempre di più, riflettendo quell’armonia tra tecnologia e ambiente che andava di pari passo con il benessere dei dipendenti: accanto alla fabbrica e agli uffici, infatti, c’erano la mensa, le residenze, i centri sportivi, l’asilo per i figli dei dipendenti e una biblioteca. Quando fecero presente a Olivetti che alcuni libri erano stati sottratti, il suo commento fu un vagamente soddisfatto: “Vuol dire che qualcuno li legge”. Ivrea unisce gli interessi di architettura di Olivetti (che nel 1938 aderisce all’Istituto Nazionale di Urbanistica e nel 1948 entra a far parte del suo Consiglio Direttivo) a una nuova concezione del lavoro, e riflette la convinzione che la fabbrica doveva integrarsi con il paesaggio circostante, rispettando un principio di armonia che portasse al miglioramento del paesaggio urbano, di cui tutti avrebbero potuto beneficiare (gli edifici della Olivetti erano costruiti in vetro, in modo che i dipendenti potessero lavorare in un ambiente luminoso e potessero apprezzare la bellezza del panorama). Com’è possibile che questo sogno industriale si sia dissolto, nonostante le solide basi che lo caratterizzavano? Michele Mezza, professore di Sociologia della cultura digitale all’università Federico II e autore del libro Avevamo la luna – L’Italia del miracolo sfiorato, vista cinquant’anni dopo, spiega che sono state una serie di congiunture negative a uccidere il sogno. Da una parte c’era l’ostilità dell’America. In quel periodo l’Italia si trovava al vertice di altri settori industriali, per esempio con l’Eni di Enrico Mattei e il nucleare di Felice Ippolito. Anche per questo la tecnologia Olivetti non era vista di buon occhio oltreoceano, quindi gli Stati Uniti non si sono fecero scrupoli a trasformare la cessione della divisione elettronica della Olivetti alla General Electric in una resa senza condizioni: “Nel mio libro – dice Mezza – è riportata la testimonianza di Elserino Piol, giovane manager che ha partecipato alla fase finale della débâcle, cercando inutilmente di limitarla. A un certo punto Piol è stato preso da parte da Roberto Olivetti, che ha chiarito che non c’era nulla da trattare, bisognava cedere su tutta la linea: era arrivato un diktat da parte del Dipartimento di Stato: pare che Fanfani avesse ricevuto una lettera di Harriman, assistente di Kennedy, che con un’espressione brutale ma esplicita gli ricordava che l’Italia la guerra non l’aveva vinta”. Poi c’erano le rivalità tra aziende: “L’Olivetti aveva un grande nemico nella Fiat di Vittorio Valletta, che scrivendo al ministro del bilancio del tempo, Giolitti, si espresse in un lapidario l’elettronica non è cosa per noi”. Lo Stato, in altre parole, doveva preoccuparsi delle autostrade, mentre la Fiat le avrebbe popolate. Il resto non doveva essere una priorità. Continua Mezza: “Nel 62 l’Olivetti entrò in una sorta di amministrazione controllata, guidata da Bruno Visentini che era anche avvocato della Fiat e vicepresidente dell’IRI. Sarà proprio lui a progettare lo scorporo della divisione elettronica e la vendita del cuore dell’azienda alla General Electric”. Un conflitto di interessi non da poco, visti i precedenti. Per finire, ricorda Mezza, c’è un clima di diffidenza in tutte le ali del Parlamento: “Da una parte la DC vedeva in Olivetti una mina vagante, mentre a sinistra veniva percepito come un concorrente: aveva creato il Movimento comunità e si era per così dire messo in proprio. E così la morsa si chiude, l’Olivetti si smembra e nessuno protesta. È impressionante scoprire che il giorno in cui viene firmato l’accordo, il 31 agosto tra l’altro, sui giornali sono apparsi soltanto degli esili trafiletti. A distruggere il sogno sono stati la congiura del silenzio della politica, l’ostilità dell’industria italiana e la guerra diplomatica ed economica degli americani.” Una visione senza confini, realmente democratica al netto di ogni ideologia politica, probabilmente non sarebbe stata stroncata da un singolo attacco: quel “sogno italiano” è stata bersagliato da più parti prima di cadere sconfitto. Dell’Ivrea di Adriano, intesa come sistema di valori che trascendevano l’ottica del profitto, è rimasto davvero poco, e forse anche entrare nel Patrimonio Mondiale lascia l’amaro in bocca: “Il riconoscimento dell’Unesco è importante perché senza dubbio Ivrea è un pezzo di cultura che va valorizzato e protetto – conviene Mezza – ma dà una stretta al cuore pensare che quella che è stata una delle più grandi innovazioni tecnologiche del secolo diventi un pezzo da museo: è la misura del fallimento del miracolo italiano”.