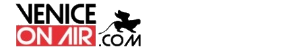La Serenissima Repubblica di Venezia come una Silicon Valley ante litteram. Un territorio di libertà, dove l’ingegno, la tecnica, il clima internazionale e il lavoro rendevano possibile a Padova, Venezia, Vicenza, Treviso, ciò che oggi accade – con ogni dovuta proporzione di tempi e mezzi – nella Silicon Valley. Porto internazionale cui si approdava da tutto il mondo e dove giungevano tecnologie e idee, Venezia ha preceduto le eccellenze di Palo Alto, San Jose, Cupertino. L’Università di Padova, nel territorio della sua Repubblica, attraeva studiosi e studenti, portatori di innovazioni e conoscenza. Secoli prima di Stanford o Berkeley. Una terra, il Nordest, con una enorme tradizione d’ingegno e creatività, ma che se ne dimentica. E sembra aver perso la capacità d’innovare e, soprattutto, d’investire nelle proprie idee. Come il Nordest, l’Italia intera. “Siamo innovatori senza memoria” afferma Massimo Sideri, giornalista del Corriere della Sera e autore del libro La sindrome d’Eustachio (Mondadori), nel quale traccia un percorso narrativo che, partendo dal Medioevo, rivela una caratteristica che ostinatamente ripete se stessa nel tempo: la scarsa capacità nazionale di riconoscere i propri meriti, le proprie qualità. “L’Italia è un paese di contemporanei, senza antenati né posteri” affermava il critico Ugo Ojetti. C’è insomma una sorta di sordità culturale italiana nei confronti dei propri innovatori, la “sindrome di Eustachio”. Chiara Mezzalira per il giornale Il Bo dell’ateneo di Padova dedica ampia recensione allo scritto di Sideri in cui si precisa che Eustachio, il cui vero nome era Bartolomeo Eustachi, era uno degli anatomisti più apprezzati nel XVI secolo, e aveva teorizzato lo studio della tromba uditiva destra. Nell’Aula di Medicina del Palazzo Bo dell’Università di Padova il suo ritratto sta a fianco a quelli di Morgagni, Vesalio, Falloppio. Una galleria di ritratti come una specie di “Facebook dell’epoca”, per Sideri, a disegnare un network di relazioni abitate da “rampolli illustri” mandati a studiare a Padova “come oggi si punta a Harvard”. Come William Harvey che, tornato in patria, sarebbe diventato il primo scienziato a descrivere il sistema circolatorio umano. Nel Teatro anatomico di Padova, infatti, grazie all’influenza veneziana, pare si potesse indulgere in autopsie umane, pur già legali, piuttosto approfondite rispetto ai consueti dettami ecclesiastici. Nelle aule dell’università il sacro e il profano convivevano. “Non è nemmeno un caso che sempre a Padova Galileo Galilei, qualche decennio dopo” ricorda Massimo Sideri, “oltre a effettuare le famose osservazioni che tanti guai gli avrebbero portato, fosse anche uso arrotondare lo stipendio di 180 fiorini all’anno vendendo oroscopi”. Nella Padova della Serenissima nacque anche il primo vero pianoforte, progettato e costruito da Bartolomeo Cristofori nella seconda metà del XVII secolo. Il padovano acquistò fama per la sua invenzione ancora in vita, tanto da essere chiamato alla corte medicea per occuparsi degli strumenti di corte. Mentre il clavicembalo già esisteva, quello che Cristofori porta a Firenze è, secondo un inventario mediceo, un “arpicimbalo (…) di nuova invenzione, che fa il piano e il forte”. E mentre il padovano esportava la sua creazione a Firenze, la Repubblica di Venezia già si era interrogata e posta il problema della tutela delle invenzioni che gravitavano sul suo territorio. Qui infatti nacquero due pilastri dell’innovazione, per dirla con le parole di Sideri: il brevetto e il copyright. La prima legislazione europea sul brevetto è infatti contenuta in un documento del Senato veneziano del 1474, redatto per “difendere la paternità dell’opera dando al soggetto che la dimostrava il diritto di riprodurre l’invenzione in esclusiva”. Lo stesso vale per il diritto d’autore, non inventato con il Copyright Act di Londra del 1710: a quella data venne ideato solo il termine “copyright”, non il privilegio di stampa praticato a Venezia fin dal tardo Quattrocento. “Gli inglesi, al limite, possono reclamare il copyright sull’uso della parola copyright”. Aldo Manuzio fu il primo stampatore a inventare il lavoro dell’editore. E il primo ideatore dei caratteri mobili a stampa non fu probabilmente Gutenberg, ma Panfilo Castaldi nel 1456, che però utilizzò fragili caratteri in vetro veneziano, facilmente lavorabili dagli artigiani. Legati alla diffusa sapienza nella lavorazione del vetro, soprattutto a Murano, anche i primi occhiali, dei quali c’è traccia documentata già tra il 1200 e il 1300, con precisi riferimenti a Venezia. Ma non ci siamo fermati alla Serenissima, perché in Italia, nei secoli, d’invenzioni ne abbiamo registrate davvero tante, e capitali: la stabilizzazione dei polimeri del chimico Giulio Natta, le prime sperimentazioni sulle cellule staminali emopoietiche del genetista Claudio Bordignon, il telefono di Meucci e perfino le matite in legno e grafite dei coniugi Bernacotti. Solo per dirne alcune. Eppure queste idee sono passate di mano o hanno trovato realizzazione altrove. O sono state semplicemente dimenticate. Anche nel primo computer c’è lo zampino italiano: il microprocessore è stato infatti sviluppato da un team guidato da Federico Faggin, fisico vicentino laureato all’Università di Padova. Peccato che quel team avesse base in California, nella solita Silicon Valley, dove Faggin si è anche trasferito stabilmente, assumendo cittadinanza statunitense, fondando e dirigendo diverse aziende innovative nel campo dell’high tech. “Abbiamo una ricerca eccellente, delle menti superiori, che però non pensano alla seconda parte dell’equazione, allo sviluppo. Le scoperte non diventano start-up, le idee non si trasformano in imprese”, scrive Sideri.