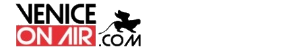Qual è oggi la realtà dell’industria della moda italiana, e cosa c’è dietro alcuni dei brand più famosi al mondo? Ruota intorno a questi interrogativi il recente studio di Davide Bubbico, Veronica Redicini e Devi Sacchetto (I cieli e i gironi del lusso, Guerini scientifica 2017), condotto su alcuni dei più noti distretti della moda italiana: quello della pelletteria in Toscana, il comparto campano del tessile-abbigliamento e la Riviera del Brenta, tra Padova e Venezia. Oggi Made in Italy significa sempre meno “fatto in Italia da italiani”, e non solo perché una parte dei processi produttivi è delocalizzata all’estero: anche in quelli rimasti nel nostro Paese l’apporto della manodopera e ultimamente anche dell’imprenditoria di origine straniera (prima la cinese) è sempre più importante. Molti dei prodotti che oggi sono in vendita per centinaia o migliaia di euro sono infatti ideati e confezionati da diversi soggetti in varie parti del mondo, in un processo complesso del quale a livello di comunicazione vengono evidenziate solo alcune fasi, mentre altre vengono accuratamente occultate. Perché il lusso è soprattutto un sogno e nessuno deve infrangerlo; un traguardo sociale da non mettere in discussione. “Quello che viene venduto attraverso un marchio non è esclusivamente un prodotto, ma soprattutto una filosofia di vita, un’etica e un’estetica”, scrivono gli autori, e non vale solo per le griffe: “Dal punto di vista di chi vende oggi la scritta Made in Italy significa la possibilità di presentarsi nei mercati esteri con un marchio che dovrebbe garantire una certa qualità e quindi un certo prezzo – ha spiegato al Bo Devi Sacchetto, docente di sociologia del lavoro presso l’università di Padova, che nel libro si è occupato soprattutto della Riviera del Brenta –. Grazie ad esso anche imprese molto piccole riescono a commercializzare i loro prodotti in Paesi come la Russia e il Giappone”. Di questo dà un ampio servizio sul giornale dell’ateneo Daniele Mont D’Arpizio il quale ha aggiunto: “La forza attrattiva dell’eleganza italiana è così potente che a volte la delocalizzazione assume un verso contrario: sono diverse le multinazionali del lusso che investono in Italia, attratte dalle nostre maestranze ma anche dalla possibilità di apporre sui loro prodotti un prestigioso marchio di origine. È proprio quello che è accaduto negli ultimi anni nella Riviera del Brenta, ormai apprezzata a livello mondiale come centro di produzione della scarpa da donna di qualità: un agglomerato produttivo tra Padova e Venezia che occupa circa 10.000 persone in 520 aziende, più del 12% del settore calzaturiero nazionale. E qui oggi sfornano i loro modelli non solo Armani e Prada, ma anche Louis Vuitton e Christian Dior. Una presenza non priva di conseguenze da un punto di vista economico e sociale”: “L’ingresso delle multinazionali del lusso negli ultimi anni da un lato ha salvato il distretto, permettendo che l’occupazione rimanesse stabile – ha spiegato Sacchetto – dall’altro però ha cambiato profondamente i rapporti di forza e l’organizzazione del lavoro. I grandi marchi si rivolgono a grandi masse, chiedono una produzione di quantità e qualità elevata ma standardizzata, con il rischio di perdere le peculiarità locali e il carattere artigianale della lavorazione”. Un elemento evidenziato nel massiccio passaggio, anche per le scarpe di lusso, alla lavorazione in catena di montaggio, dove il ritmo automaticamente predeterminato elimina sempre più quell’autonomia che caratterizzava il lavoro artigianale. Creatività e autonomia che oggi tengono a concentrarsi nella fase a monte del processo produttivo vero e proprio, ad esempio nel lavoro dei designer e modellisti. In un mercato globale della moda sempre più dominato dalle grandi corporation, solo poche aziende di medie dimensioni riescono ancora a produrre e a commercializzare con il proprio marchio, mentre tante lavorano soprattutto come terziste o fornitrici dei colossi del settore. Come mai in Veneto non si è riusciti a fare quel ‘salto’ internazionale che altrove invece è riuscito, generando marchi in grado di imporsi a livello mondiale? “A parte alcuni casi, forse è mancata soprattutto la capacità di commercializzare i propri prodotti – ha aggiunto Sacchetto – Alcuni tentativi negli anni scorsi ci sono stati ma non sono andati a buon fine, soprattutto perché le piccole imprese non sono riuscite a fare sistema. Oggi nelle Riviere continuano ancora a esistere aziende indipendenti con buoni fatturati, ma il loro numero è molto limitato”. Quello che spesso non viene detto è che anche i processi rimasti in Italia impiegano sempre più lavoratori e imprenditori stranieri: nel distretto calzaturiero esistono infatti 100-150 imprese gestite da cittadini cinesi, quasi tutte operanti in subappalto o sub-subappalto. “Bisogna ammettere che anche queste aziende riescono a mantenere buoni livelli qualitativi. Spesso infatti la questione fondamentale non è quella del costo ma della flessibilità, con tempi di consegna molto stretti per rispondere esigenze mercato mondiale”. Che fare per evitare che questo si risolva in turni di lavoro massacrante e sottopagato? “Magari i sindacati, invece di stigmatizzare la situazione, potrebbe assumere qualche operatore cinese in più per provare a sindacalizzare questi lavoratori”. Anche nel nostro Paese insomma possono riprodursi le dinamiche della delocalizzazione (a partire dal dumping salariale e dalla riduzione dei diritti dei lavoratori), dando luogo a quella che i tre autori chiamano delocalizzazione di prossimità. Questo però non toglie l’enorme fascino che il gusto italiano riesce ancora a esercitare nel mondo.