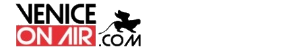I musei di paleontologia, archeologia, probabilmente antropologia e zoologia sono legati da una tenue linea rossa: “Prima del Settecento essere uno scienziato comprendeva tante discipline, scientifiche e umanistiche, non c’era la divisione che conosciamo oggi”, ha spiegato Paola Nicolosi, conservatrice del museo di Zoologia dell’università di Padova. Quella linea ha un nome e un cognome: Antonio Vallisneri. Che non è una persona, bensì due: senior e junior. È grazie al padre che esiste una collezione zoologica a Padova; è per merito del figlio se questa appartiene, oggi, all’ateneo. Su questo dedica un suo scritto Damiano Martin su ViviPadova, la spazio riservato agli studenti dell’ateneo. Nell’anno 1730 è morto Vallisneri senior, biologo, naturalista, scienziato e medico toscano, docente di medicina teorica e medicina all’università di Padova dal 1700. Il figlio dona la sua collezione naturalistica allo stesso ateneo e, quattro anni più tardi, viene incaricato docente della prima cattedra in Italia di storia naturale, nonché curatore di quella che viene denominata collezione vallisneriana. Collezione che viene esposta a palazzo Bo, fino a circa metà dell’Ottocento. Sarà poi Stefano Andrea Renier, successore del Vallisneri figlio (dopo 30 anni di vuoto) a “smembrare” il museo nelle sue varie parti: naturale, scientifica, archeologica. È il 1806. Il museo di Zoologia arriva nelle stanze di via Jappelli 1A dopo aver peregrinato tra la scuola di san Mattia, vicino agli Ospedali, e via Loredan. Sono gli anni Settanta, nei quali tutto il settore museale dell’università viene dimenticato nei depositi dell’ateneo. Così come per il museo di Educazione o quello di Antropologia, bisogna aspettare vent’anni prima che qualcosa si smuova. Per quanto riguarda Zoologia, è il 2000 l’anno della svolta, con il concorso pubblico per assegnare l’incarico di conservatore del museo. Lo vince Paola Nicolosi: curioso che sia un’altra toscana, come i Vallisneri, a riprendere in mano le redine della collezione. “Abbiamo lavorato quattro anni, tra riordino e catalogazione, prima di rendere agibili almeno due sale, grazie al lavoro delle professoresse Turchetto e Casellato e degli studenti e volontari che ci hanno dato una mano”. La prima delle due stanze in questione ospita la vetrina degli invertebrati: circa un centinaio, tra molluschi, insetti e animali alquanto repellenti immersi nell’alcol. Inoltre c’è la parte storica del museo: la vita di Vallisneri senior e due racconti affascinanti. La tartaruga liuto imbalsamata non è la più antica al mondo: a Bologna infatti esiste un esemplare precedente, rimasto trascurato. Per questo Carlo Linneo, quando catalogò tutti gli essere viventi presenti sul pianeta, prese come riferimento l’esemplare di Padova. E non è tutto, annota ancora Damniano Martin: entrambe le tartarughe liuto furono donate da due papi alle rispettive università presenti nella città di provenienza. Prima Benedetto XIV a Bologna, poi Clemente XIII (che non voleva essere da meno) a Padova, nel 1760. L’altro racconto fascinoso riguarda il dente di Narvalo, conservato nella teca di vetro insieme al corno di rinoceronte nero. Racconti leggendari fomentati dai tassidermisti, coloro che trattano la conservazione di animali morti e che in antichità si divertivano a “scambiare parti di animali. È così che sono nate le chimere, e il dente di Narvalo un tempo veniva spacciato come corno di unicorno”. Nella seconda sala invece è stata raccolta la biodiversità mondiale. Animali esotici, per riassumere, imbalsamati, che raccontano piccole storie, della specie che esemplificano e di chi li ha “pietrificati”. Da una parte, una svariata selezione di primati; lungo il corridoio, uccelli esotici e felini (su tutti, le due tigri del bengala, rossa e bianca). Ma a farla da padrone qui è un pachiderma, meglio conosciuto come l’elefante di Venezia. Difficile immaginare un animale così grosso per le calli veneziane. Eppure… “era usanza durante il Carnevale esibire animali esotici come l’elefante. Nel 1819 questo si liberò, dopo aver stritolato un uomo, e scappò per i ponti. I colpi di fucile non servirono a niente: per la fortuna dei soldati, si incastrò nella tomba pavimentata della chiesa di sant’Antonino. Da lì le milizie austriache riuscirono a sparargli nel didietro per ucciderlo”. Fu il professor Renier ad andare a prendere la carcassa, ed è grazie a lui che oggi possiamo vederla esposta nel museo di Zoologia, ancora segnata dagli spari (ma non dalla cannonata). La terza e la quarta sala invece comprendono la fauna autoctona, o quella che dovrebbe essere tale ma rischia l’estinzione a causa dell’uomo. È il caso dell’orso, per esempio: se da un lato è pericoloso, dall’altro l’uomo è probabile istigatore della sua violenza, nonché disabituato alla sua presenza. Questione di equilibri. All’opposto, il lupo sta ripopolando in questi anni le nostre montagne: Il lupo degli appennini ha risalito la catena montuosa, mentre quello sloveno è sceso. I due si sono trovati sui monti Lessini e hanno iniziato a procreare: il lupo sta ritornando anche sulle nostre montagne”. L’ultima sala invece, ricavata dal laboratorio del museo, è riservata alla fauna adriatica. Qui si può scoprire che il delfino, come lo immaginiamo solitamente, non è il delfino, ma il tursiope; il cetaceo su cui fantastichiamo è leggermente diverso. E poi esiste un altro animale simile, il grampo, contraddistinto da segni ed escoriazioni grigio chiaro sulla pelle più scura: “è la loro dimostrazione d’affetto – ha precisato Nicolosi – si mordicchiano la pelle”. In questa sala è presente l’unico modello plastificato del museo, lo squalo. E il cranio di un capodoglio, arrivato dalle parti della sala necroscopica del museo di medicina veterinaria.