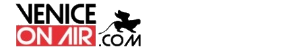Non è la prima volta che il Festival del Cinema di Venezia si interessa alle nuove tecnologie. Sono ormai una quindicina le edizioni della Mostra che registrano prime visioni di film in alta definizione, proiezioni in 3D, workshop e conferenze che provano a far luce sulle evoluzioni in atto. L’istituzione di una sezione del Festival dedicata alla realtà virtuale segna però un nuovo livello di interesse sull’argomento e offre l’occasione per alcune riflessioni in merito ai rapporti tra cinema e dispositivi tecnologici. Se oggi parlare di cinema digitale significa parlare del cinema tout court, di tutta la produzione contemporanea che, salvo ridotte eccezioni ancora legate alla pellicola, viene realizzata attraverso immagini numeriche, l’interrogativo sul quale ragionare, scrive Denis Brotto sul giornale Il Bo dell’ateneo di Padova, è connesso al che cosa la tecnologia possa offrire in termini di novità per quanto riguarda forme narrative estetiche, esperienziali. I media digitali hanno infatti contribuito in modo determinante a rendere il racconto filmico un territorio di esplorazione e di intreccio tra reale e virtuale, tra referente fisico e richiamo artificiale. Dopo le sezioni rivolte ad opere realizzate in VR del Tribeca Film Festival e del Sundance Festival, la Venice Virtual Reality si presenta ora come la prima rassegna competitiva dedicata ai VR film, con 22 opere in concorso divise nelle categorie Virtual Theater, Stand Up e installazioni. Tra i titoli proposti, molti indagano temi storici o di attualità di grande impatto, come l’Olocausto, i rischi ambientali, la violenza, il ruolo della tecnologia stessa nel nostro vivere. L’intento comune di questi lavori è tuttavia quello di far provare allo spettatore che cosa significhi ritrovarsi, in prima persona, letteralmente immersi all’interno del contesto narrativo. Bastano un paio di cuffie e un visore. Dopodiché Nothing Happens, Greenland Melting, The Argos File, Bloodless ci portano ad una forma di inabissamento (in Arden’s Wake ciò avviene in modo testuale) in un ambiente visivo ora esplorabile a 360°, con un uso della soggettiva che massimizza quella che Metz definisce «identificazione primaria»: non solo lo sguardo dello spettatore coincide con quello della macchina da presa, ma anche il suo corpo appare ora interiorizzato dallo strumento ottico. La camera insabbiata di Laurie Anderson prova ad abbattere i confini tra reale e spazio filmico permettendo non solo di muoversi sul piano orizzontale, ma anche di simulare l’esperienza del volo, lasciando inoltre che la nostra voce prenda forma e concretezza lungo le pareti di questa immensa camera virtuale. Fuori concorso si ritrovano alcune opere note al pubblico del settore, come l’effluvio di colori e memorie di Dear Angelica e il racconto toy-oriented di Miyubi, in cui ancora una volta lo spettatore è chiamato ad esperire in prima persona le vicende narrate. Le opere selezionate sono prevalentemente legate all’ambito dell’animazione, al VR Theather e alle videoinstallazioni, rimarcando l’esistenza di zone franche entro cui cinema e altri linguaggi artistici hanno costruito negli anni un dialogo fluido. E proprio nella convergenza tra realtà e virtuale, tra performance e immaginazione, tra cinema e altri linguaggi risiede sia il principale fattore di novità di questa proposta, sia il maggior interrogativo in merito al suo relazionarsi alle forme canonizzate del cinema. Qualcuno parla non a caso di post-cinema, altri osservano l’influenza dei videogame, altri ancora intravedono, in filigrana, il segnale di marketing: non è né un caso né un mistero che innovazioni tecniche, 3D e ora formati VR abbiano maggior risalto nei momenti storici in cui il mercato del cinema registra una flessione. Ma la vera questione continua ad essere la comprensione del ruolo di queste forme tecnologiche in relazione alle funzioni del cinema, al suo linguaggio. È evidente, sostiene ancora Brotto, come queste tecnologie abbiano saputo sviluppare una potentissima facies innovativa. Ma l’innesto della novità tecnica avviene puntualmente all’insegna di una dicotomia tra quanti si limitano a replicare, attraverso il nuovo, forme canonizzate del passato e quanti vi intravedono invece possibilità di mutazione e sviluppo del linguaggio cinematografico. Tali aspetti portano con sé altrettante incognite. Nel primo caso, quella di perdere la necessaria dimensione evolutiva del cinema, la sua componente di inventio. Nel secondo, quella di salutare il cambiamento di tecnologia con la volontà di recidere in modo netto il cordone ombelicale legato al passato, generando il pericolo di una perdita di identità, di un’assenza non solo genealogica, ma anche strutturale per il nuovo corso delle immagini in movimento. Nel loro guardare al futuro, le nuove tecnologie mantengono valore se sanno ripristinare uno sguardo rivolto a recuperare una memoria, un passato da far rivivere attraverso quella “euforica fioritura” di cui parla Moholy-Nagy, senza tradire il basilare legame tra immagine e immaginazione. Ben vengano allora le configurazioni della realtà virtuale, a patto di non dimenticare che per segnare un’innovazione è necessario prima di tutto essere in grado di “interrogare il passato”, i canoni del linguaggio cinematografico, rinnovando il confronto tra forma e immaginazione, tra visione e riflessione. Solo attraverso questo declivio che “dal nuovo porta al vecchio” è allora possibile osservare e valutare il carattere immersivo del VR e il suo tentativo di inabissamento tra le maglie del virtuale, andando al di là di quel piacere epidermico che prova lo spettatore nel divenire parte attiva all’interno della rappresentazione. “Il cinema è la possibilità di vedere la farfalla laddove non c’è che la crisalide” ci ricorda Jean Epstein e, a quasi un secolo di distanza, sono ancora le sue riflessioni ad aiutarci a capire quale sia non solo il potenziale, ma anche il compito del cinema, e con esso delle nuove tecnologie di ogni epoca: dare forma all’immaginazione. E ciò non necessariamente facendone esperienza attraverso un suo surrogato. Ad agosto, intanto, è stato inaugurato a New York, a pochi passi dall’Empire State Building, il più grande centro VR aperto al pubblico, il VR World. Chi lo desidera può accomodarsi nella propria postazione, indossare gli immancabili cuffia e visore, e vivere l’esperienza della realtà virtuale. Strano a dirsi, ma da fuori la sensazione è di assistere a una versione contemporanea del Kinetoscopio inventato da Edison alla fine dell’Ottocento. Anche in quel caso immersione e soggettività dell’esperienza erano i caratteri primari di quel tipo di proiezione.