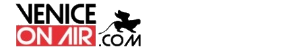Sono medici laureati all’università di Padova: giovani e meno giovani, uomini e donne che scelgono ogni anno di spendere almeno una parte della loro vita e della loro professione nelle zone più povere del mondo. Chi per qualche settimana, chi per diversi mesi: l’importante è dare un contributo, per crescere umanamente ma anche professionalmente. Come Alberto Tredese che, in occasione della laurea in medicina ottenuta l’estate scorsa, ha deciso di “regalarsi” cinque settimane nell’ospedale St. Elizabeth di Arusha, in Tanzania: “Volevo soprattutto dare una mano – racconta – ma anche vedere com’è il mondo là fuori, uscire dalla mia comfort zone”. Per realizzare il suo progetto Alberto, che nel tempo libero è anche volontario della Croce Rossa, ha fatto una semplice ricerca online che alla fine lo ha portato a scegliere una società internazionale (di nome A Broader View) che organizza progetti di volontariato in tutto il mondo. Così è iniziata l’esperienza in Africa, dove Alberto ha svolto principalmente le mansioni di anestesista, la stessa specializzazione che spera di intraprendere nel prosieguo del suo curriculum accademico. Un’esperienza non semplice – in Tanzania il Pil pro capite è inferiore a 3.000 dollari, meno di un decimo di quello italiano, mentre la speranza di vita è di appena 61 anni – ma comunque arricchente: “Avevo a disposizione a malapena gli anestetici e i medicinali di base; ogni giorno ad esempio, assieme agli altri medici e infermieri, dovevamo sterilizzare manualmente le garze e le bende che ci sarebbero serviti il giorno successivo con l’acqua bollente”. Per questo prima di partire il giovane professionista ha fatto una colletta tra amici e parenti per acquistare medicinali e attrezzature: “Verificate con i colleghi le necessità della struttura, abbiamo comprato sul posto antibiotici, test per la sifilide, glucometri, pulsiossimetri, fluidi da infusione, contenitori e reagenti per il laboratorio, antidolorifici e test per le urine. Abbiamo acquistato anche un aspiratore per la sala operatoria: fino a quel momento ci si serviva di una pompetta a mano”. Un’esperienza di volontariato, ma anche una scuola utile per la vita e per la professione: “Infermieri e medici dell’ospedale mi hanno subito accolto con fiducia: con loro ho imparato a gestire ogni situazione, dando un servizio dignitoso pur nella scarsità delle risorse. Inoltre vivevo in appartamento assieme a volontari da tutto il mondo: medici, ingegneri ed educatori, ma anche muratori e operai venuti semplicemente per dare una mano. L’Africa mi è entrata nel cuore e prima o poi voglio tornare. Simile e diversa allo stesso tempo la storia di Angela Onisto, ventiduenne laureata in ostetricia che sta passando un anno a San Lorenzo, città di 40.000 abitanti nel nord dell’Ecuador. E’ raccontata in un servizio del Bo a firma di Daniele Mont D’Arèizio. La dottoressa, arrivata con i missionari comboniani, lavora nell’area maternità dell’ospedale locale: “Nel reparto ci sono circa 800 nascite all’anno e nei primi due mesi ho assistito a più parti che in due anni di tirocinio a Padova”. Anche qui le condizioni sono più difficili di quelle a cui siamo abituati, tra la concorrenza delle parteras (le levatrici popolane volenterose ma spesso anche pericolose) e le numerosissime gravidanze precoci: per le ragazze il primo figlio arriva normalmente a 14 anni, a volte addirittura prima.
Eppure anche per Angela l’esperienza da volontaria è l’occasione per dare senso e concretezza alle competenze acquisite durante gli anni dell’università: “Vedere la vita nascere è la cosa più bella del mondo e io ne sono sempre stata convinta. Qui a San Lorenzo inoltre l’ostetrica non si occupa solo del parto: è un punto di riferimento per tutta l’età fertile della donna, una confidente e una persona di supporto. Posso prescrivere farmaci, mettere in atto tutto quello che ho studiato. Anche se a volte durante il travaglio manca la carta per fare il tracciato delle contrazioni”. Si parte all’inizio del proprio percorso per mettere alla prova le proprie competenze e per trovarvi un senso più ampio; ma si parte anche da professionisti maturi, per ritrovare le motivazioni che il tran tran burocratico della sanità moderna rischia di spegnere. “Nelle persone in Sierra Leone trovi ancora molto rispetto, mentre spesso da noi in Italia oggi i pazienti pensano di saperne più di te solo perché hanno cercato su Internet… Io però non ho mai visto nessuno operato da Internet o da un’e-mail”. Mario Pizzali è laureato in medicina da trent’anni ed è anestesista all’ospedale di Mirano (VE); tra il 2007 e il 2009 ha prestato assistenza presso l’ospedale di Goderich, alla periferia di Freetown in Sierra Leone, per un totale di nove mesi suddivisi in due periodi: “Prima della pensione però spero di fare almeno un’altra missione. Avevo provato già a fare delle piccole missioni di qualche giorno – racconta il medico – ma poi mi sono convinto che per fare qualcosa di veramente buono avevo bisogno di periodi più lunghi, in un’organizzazione abbastanza strutturata da garantirmi condizioni accettabili per lavorare”. Ciò nonostante anche qui le differenze con l’Italia erano molteplici: “L’orario non esisteva, svolgendo la mansione di caporeparto potevo essere chiamato in qualsiasi momento”. Bisognava poi adattarsi alle tecnologie disponibili, pur mantenendo un elevato livello professionale: “Faccio un esempio: tutti vorrebbero una Ferrari, ma se devo attraversare un campo arato preferisco avere il miglior trattore sul mercato”. Per lo meno la guerra civile che aveva insanguinato il paese era finita: “Trattavamo soprattutto casi di chirurgia d’urgenza, incidenti stradali o sul lavoro, traumatologia in genere. Una delle patologie più frequenti era l’addome acuto da perforazione da tifo”. Cosa si impara operando in quelle condizioni? “Una cosa molto semplice: in Europa noi medici lavoriamo per l’immortalità, in altri paesi si lavora ancora per la vita. Confrontando due mondi si imparano molte cose: impari a distinguere l’essenziale”.